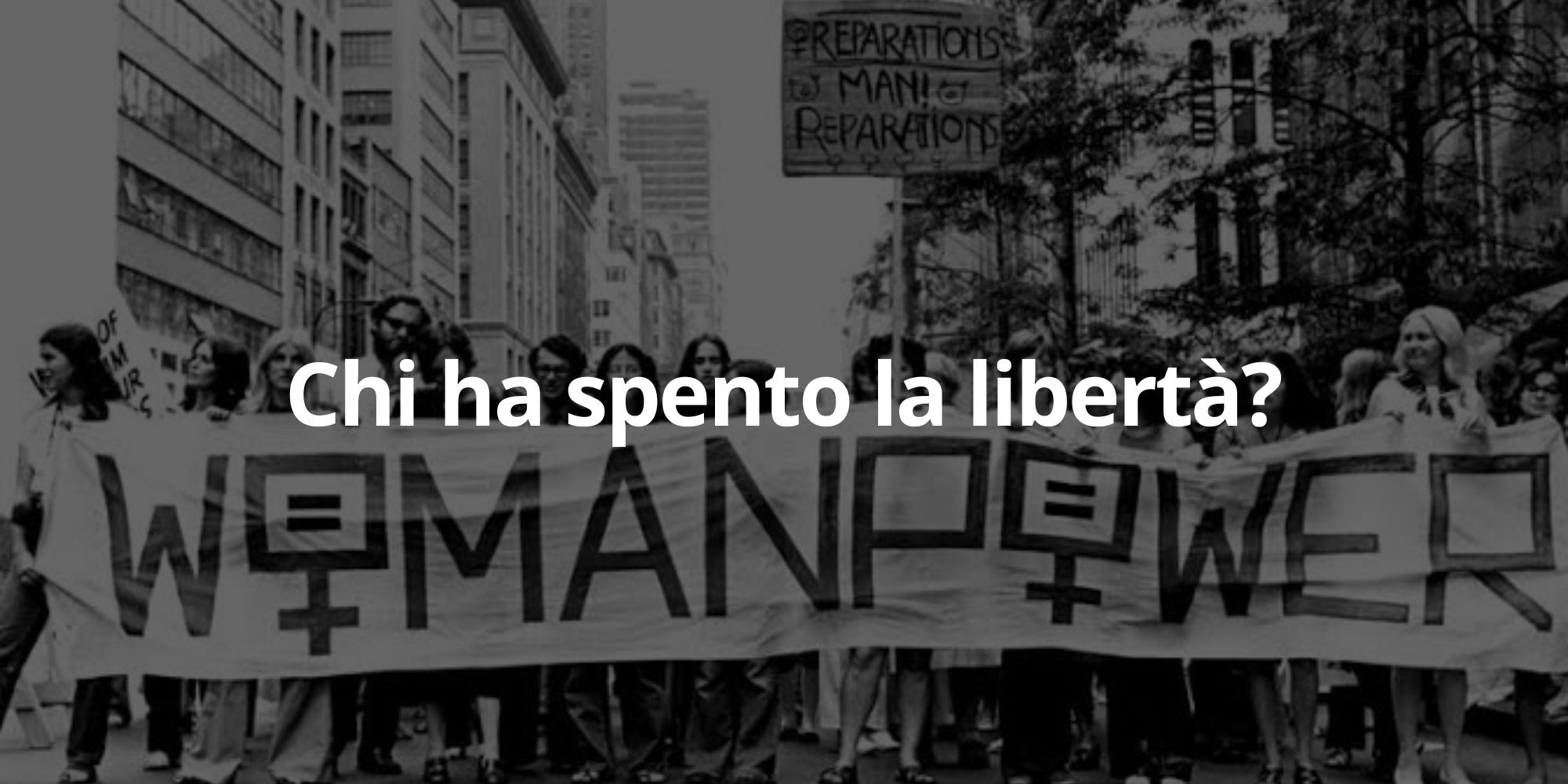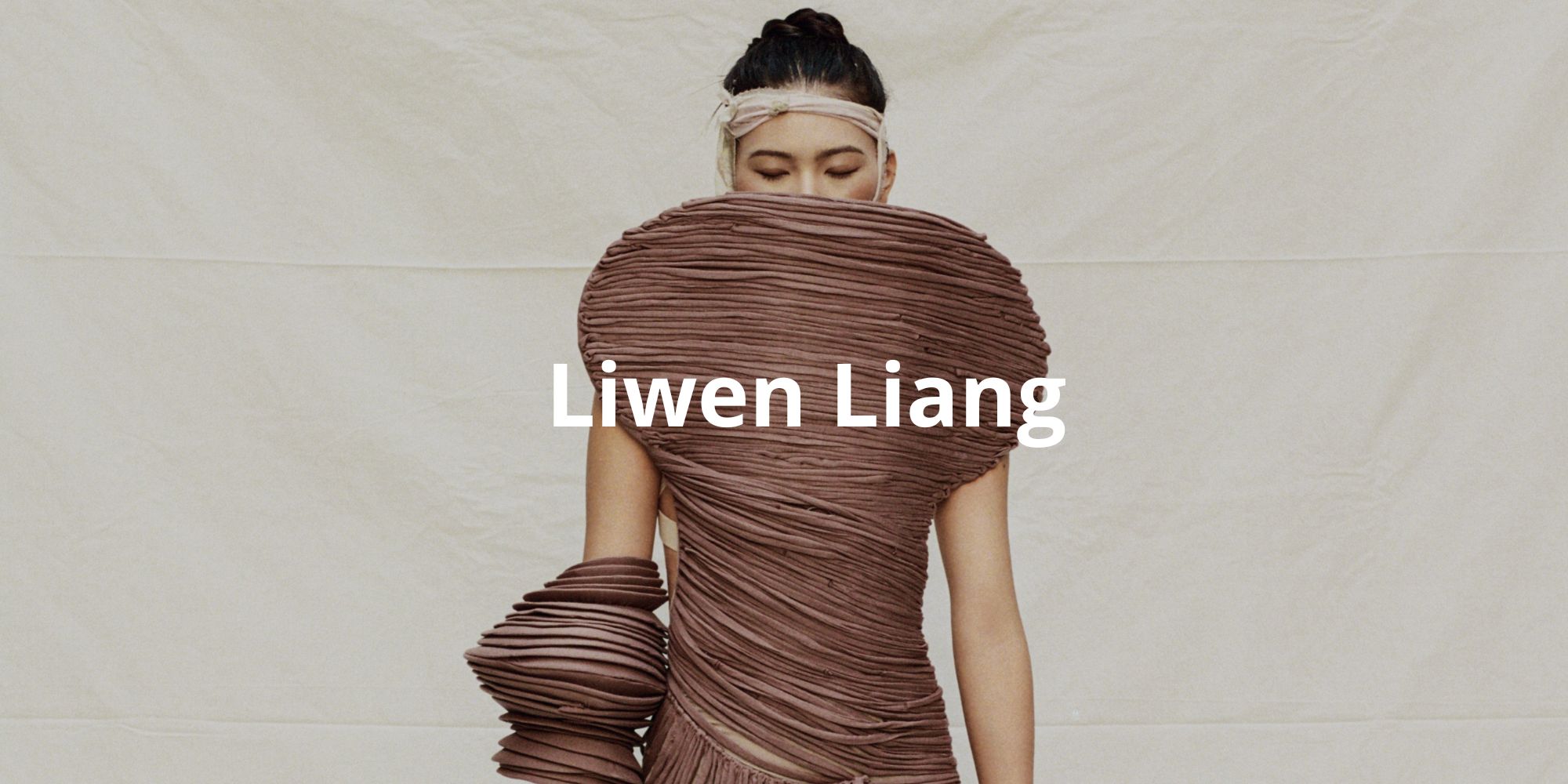Il settore del Made in Italy è una delle eccellenze del nostro paese, ma tra momenti di crisi e di crescita (relativa) qual è l’attuale situazione del “fatto in Italia”?
L’Italia è pasta, sole e mandolino. Anche se a dirla tutta io questo mandolino l’avrò visto forse una volta in una cena sulla costa di Napoli, non l’avrei inserito in questo luogo comune. Un’altra cosa che però è globalmente riconosciuta come eccellenza del nostro paese è il Made in Italy.
Un marchio dal valore globale che simboleggia l’eccellenza e la qualità distintiva della produzione italiana.
Eccellenza artigianale, innovazione e design, ma sopratutto qualità dei materiali. Il Made in Italy è sinonimo di saper fare manuale, di cura del dettaglio e tradizione, a volte lunga secoli. Non si parla di un mero processo produttivo, ma di un’arte tramandata di generazione in generazione. C’è da dire poi, che la filiera produttiva nostrana è caratterizzata per un’attentissima selezione di materie prime, rigorosamente di alta qualità. Che siano tessuti, pellami o metalli, quando si parla di Made in Italy, stampiamo un timbro invisibile che rende i prodotti eccellenti e di qualità.
Da apprezzare anche la direzione di sostenibilità ambientale e sociale che le produzioni italiane stanno sempre più imponendo nella realizzazione dei propri prodotti. Un esempio è la tracciabilità della filiera, spesso “corta” e locale, ci assicura che i diritti dei lavoratori siano stati rispettati e che l’impatto ambientale sia ridotto.
Made in Italy è una combinazione di artigianato, creatività, qualità dei materiali e sostenibilità che crea un’immagine di lusso, stile e affidabilità riconosciuta, amata e voluta da tutto il globo.

Questo concetto di marchio di qualità nasce e si afferma nel secondo dopoguerra, precisamente tra gli anni ‘50 e ‘80. Nonostante la tradizione artigianale italiana risalga al Rinascimento, l’idea di utilizzare l’etichetta “Made in Italy” come strumento di identificazione nazionale e anche marketing, perchè no, è un fenomeno più moderno.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia inizia una fase di ricostruzione e di grande crescita economica, il cosiddetto Miracolo Economico. L’industria italiana, nello specifico il settore della moda, del design, dell’automotive e dell’arredamento, inizia a farsi notare a livello internazionale.
Emilio Schubert, le Sorelle Fontana e Emilio Pucci, presentano le loro creazioni, attirando così l’attenzione del mondo intero.
Negli anni ‘70 la moda italiana da Roma si sposta a Milano, diventando così un’industria più strutturata e vicina ai distretti produttivi del nord. Proprio in questo decennio i marchi italiani si vanno ad affermare come veri e propri concorrenti dell’alta moda francese.
Negli anni ‘80 si inizia ad usare l’etichetta “Made in Italy” per promuovere in maniera massiccia e distinguere la produzione nostrana dalle imitazioni.
Ecco che arrivano Armani, Versace e Dolce&Gabbana, ambasciatori di questo successo. Gli anni ‘80 e ‘90 furono un decennio di grande successo economico, oltre che un momento cruciale per la definizione dell’identità e del prestigio globale per il Made in Italy. E’ proprio con l’ascesa di stilisti e marchi che oggi sono i pilastri della moda mondiale che la moda italiana arriva alla ribalta internazionale, superando il modello parigino e creando uno stile riconoscibile.
Assieme all’alta moda, si sviluppa anche un segmento di lusso più “democratico”, che però non abbandona l’alta qualità, permettendo al Made in Italy di inserirsi in mercati ancora più ampi.
Nei primi anni 2000 il Made in Italy affronta però i primi momenti di crisi strutturale. Un processo graduale causato da una combinazione di fattori sia globali che interni.
Arriva la globalizzazione, l’apertura dei mercati e la crescita economica di Paesi emergenti come la Cina, portano a una concorrenza basata su prezzi molto più bassi. Molte aziende italiane spostano parte della produzione all’estero, andando così a minacciare quello che era un punto di forza del Made in Italy, ossia la filiera “corta”. Insomma, la sicurezza che il prodotto fosse interamente prodotto nel “Bel Paese”.
I distretti poi, cuore pulsante del sistema, hanno fatto molta fatica ad adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato. Molte piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, hanno mostrato difficoltà a innovarsi e ad investire in tecnologia e marketing digitale.

Uno dei problemi che tutt’ora il mondo produttivo del Made in Italy si porta dietro è la mancanza di ricambio generazionale.
I giovani non sono più interessati ai mestieri artigianali, in quanto percepiti come meno remunerativi o prestigiosi, portando quindi a una progressiva perdita di competenze e saperi, che come dicevamo prima, sono per la maggior parte tramandati.
Un altro problema, che tutt’ora risulta ancora forte, è l’aumento dei costi di produzione. L’Italia ha una burocrazia complessa e un carico fiscale elevato, riducendo quindi la competitività delle piccole imprese e dei laboratori artigianali in confronto ai Paesi con costi operativi inferiori.
Attualmente il mondo del “fatto in Italia”, nel settore dell’artigianato e della produzione di capi e accessori, sta affrontando una situazione complessa che presenta, però, sia aspetti positivi che criticità, in contrasto con i dati interamente negativi visti in passato.
Il valore della produzione del settore artigianale italiano, ad esempio, ha mostrato una crescita. Nel 2022 ha raggiunto i 113 miliardi di euro, portando a un aumento del 3,5% rispetto all’anno prima. L’export oggi risulta un grandissimo punto di forza, forte dell’amore che l’estero prova verso i prodotti fatti in Italia. Si parla di un valore di oltre 35 miliardi di euro, con performance elevate per Food & Beverage e oreficeria. Settori che hanno visto una performance positiva anche nel 2024 e nel primo trimestre del 2025.

Nonostante la crescita economica, però, il numero di artigiani attivi continua a diminuire. Infatti, a fine 2024 il numero era calato del 5% rispetto al 2023, con una riduzione di 72,000 unità. Questo, purtroppo, è definibile come un trend strutturale che si porta avanti da tempo, registrando un calo del 22% in dieci anni.
Le imprese artigiane, poi, affrontano una difficoltà enorme nel trovare personale qualificato. Nel settore della moda si registra una difficoltà di reperimento per il 64% delle figure richieste.
L’aspetto demografico è davvero il tasto più dolente. Considerato anche il progressivo invecchiamento della popolazione artigiana e la mancanza di ricambio generazionale, si rischia davvero di far scomparire mestieri e saperi tradizionali.
Ma non demoralizziamoci: c’è un aspetto di vitalità, con oltre 83.000 nuove imprese artigiane nate nel 2024. Questo nonostante la contrazione complessiva del numero di artigiani ancora significativa.
Quindi il valore complessivo di crescita del settore è solido, l’export si riconferma come traino importante per il settore intero. Però poi c’è la forte mancanza di personale e una persistente crisi causa dalla situazione del ricambio generazionale che tira verso il basso tutto il segmento. Questo sia nell’artigianato tessile che nell’ambito agroalimentare. Finendo per definire strutturale la riduzione numerica di artigiani all’attivo.

Ecco il paradosso: il settore del Made in Italy, per quanto riguarda l’artigianato, è economicamente forte e in crescita per produzione e export, ma strutturalmente fragile per la demografia e la carenza di manodopera.
Ma com’è possibile?
Ricordiamoci che la crescita economica e il successo del Made in Italy sono principalmente guidati dalle grandi aziende del lusso. Questi sono il motore che traina l’intera filiera creando una domanda costante di prodotti di alta qualità. Queste aziende si concentrano, inoltre, su un segmento di mercato molto specifico, quello del lusso, uno dei meno sensibili alle fluttuazioni economiche. I clienti di questa fascia ricercano l’esclusività e la qualità e sono disposti a pagare anche un prezzo finale abbastanza alto per avere un prodotto Made in Italy come si deve.
Inoltre, l’aumento dei costi di produzione, dovuto anche alla strutturale mancanza di manodopera, viene trasmesso anche al prezzo pagato dal cliente. Questo viene accettato dal consumatore, sopratutto quello del lusso, come parte del valore del prodotto. Ma non tutti possono interessarti a un fatto a mano italiano ed ecco che si fa riferimento a un solo bacino di clienti, che per quanto ricchi, non saranno mai sufficienti per coprire tutte le lacune lasciate da chi “guardo, ma non tocco”.
Molte grandi aziende, hanno adottato strategie pensate per mitigare l’impatto della crisi della manodopera in Italia.
Comprando i piccoli laboratori artigianali e le imprese specializzate, i grandi marchi garantiscono la continuità della produzione, preservano il know-how e risolvono il problema del ricambio generazionale, integrando queste realtà nella propria struttura aziendale, molto più ampia e solida.
Si inserisce anche la delocalizzazione che sposta la produzione di alcuni componenti o fasi del processo produttivo in Paesi con costi più bassi, mantenendo quelle che sono le fasi cruciali del tocco artigianale in Italia. Così i costi rimangono competitivi, mantenendo però l’etichetta Made in Italy.
L’export rimane il punto di forza, la domanda per il fatto in Italia è globale e in continua espansione, anche adesso.
Insomma, il prestigio e la reputazione del marchio sono così forti che la domanda continua a superare i problemi di produzione interni.

Il gioco rimane comunque in mano ai “potenti”, sono infatti le grandi imprese del lusso a prosperare e a mantenere il settore in attivo. A soffrire sono le piccole realtà artigianali, che continuano a lottare con la carenza di personale e la mancanza di ricambio generazionale. Portando a una crisi del sapere artigianale, una perdita che nessun bilancio di qualche grande azienda del lusso può colmare.
Alla fine il paradosso sta nel fatto che la ricchezza generata in cima alla piramide permette all’intero settore di apparire “in crescita” nei dati aggregati, ma la realtà è che il Made in Italy nasconde delle profonde difficoltà che affliggono la base produttiva di questo sistema di eccellenze.