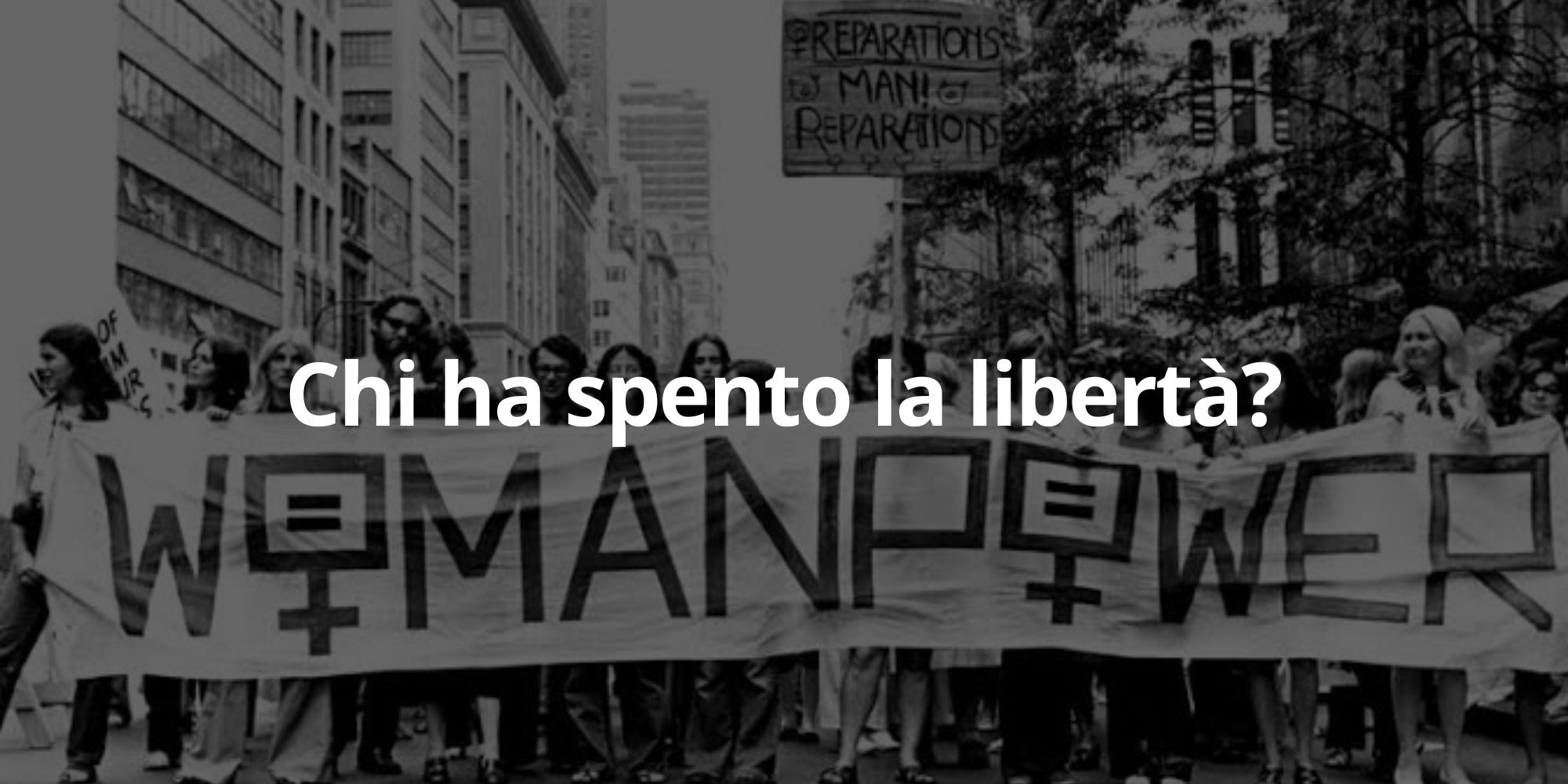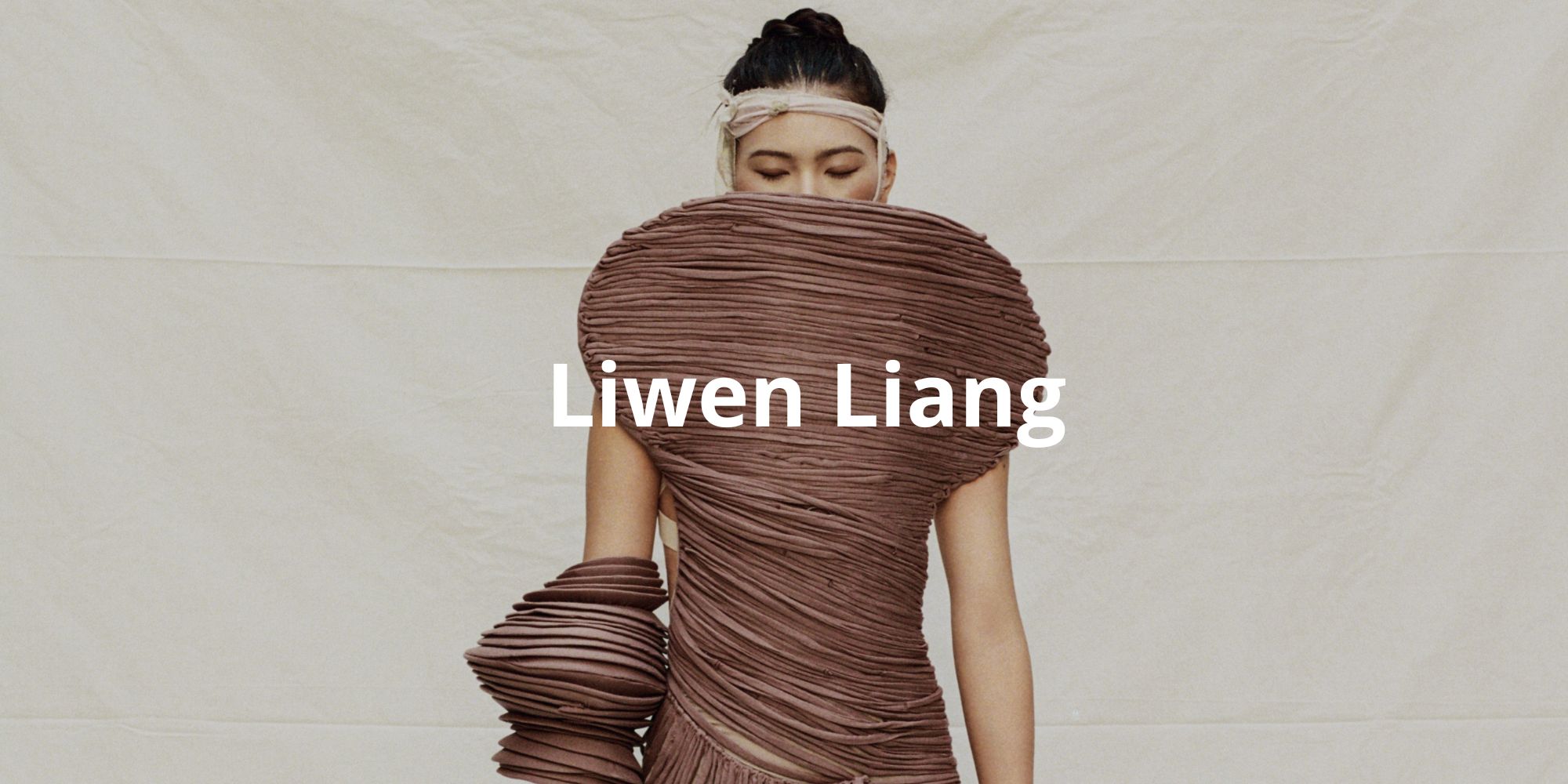Le società comunicano in tantissimi modi, tra questi ci sono i rituali pubblici. Gender reveal o Festival di Sanremo che sia, gli individui hanno mille modi per interagire, anche quando non se ne rendono conto.
iI micro-rituali sono delle dinamiche sociali che secondo la sociologia della comunicazione sono alla base della società. I rituali pubblici ci permettono poi di comprendere come le società si organizzano, mantengono la coesione e danno senso a eventi e valori condivisi. Insomma, i gender reveal in pieno stile partenopeo ci dicono molto più della cultura del paese di quanto possa fare un documentario mirato.
I rituali pubblici sono azioni simboliche collettive che si svolgono in spazi aperti o accessibili al pubblico.
A differenza delle routine di tutti i giorni, i rituali hanno una struttura specifica. Un inizio e una fine chiari. Spesso, poi, coinvolgono oggetti, gesti e parole con un significato particolare. Lo scopo principale di questi è esprimere e rafforzare valori, credenze e identità collettive. Non si limitano al mondo della religione, ma prendono anche la sfera politica, sociale e culturale.
Questi rituali creano un senso di appartenenza: partecipando a un evento collettivo, gli individui si sentono parte di un gruppo più grande. Il sentire di appartenere a una comunità rafforza l’identità sociale e il legame con gli altri membri. Ma soprattutto vengono rafforzati i valori sociali. Si mettono in scena e così vengono celebrati, con un processo che li rende concreti e li trasmette alle nuove generazioni, garantendone la continuità.
Il festival di Sanremo, ad esempio, è un tipico rituale pubblico di massa che si ripete ogni anno e riflette diversi aspetti della cultura italiana.

Per una settimana all’anno, milioni di italiani accendono la televisione sullo stesso canale. Si commentano gli stessi avvenimenti e si partecipa anche a un dibattito nazionale che unisce persone di diverse generazioni, classi sociali e regioni. Si crea con il festival una specie di comunità temporanea che si ritrova unita da un evento comune. “Cuoricini”, diventando il tormentone di quest’anno ha creato un legame emotivo condiviso da chiunque avesse assistito al rituale, ma non solo.
La carica emotiva, tra l’altro, è un aspetto fondamentale dei rituali pubblici. Pensate a chi si trova nel pubblico dell’Ariston durante la settimana santa della musica italiana. La partecipazione a un rituale pubblico può generare un senso di esaltazione, comunione e solidarietà. Uno dei padri fondatori della sociologia, Durkheim, la definiva “effervescenza collettiva”. Il momento in cui i singoli si sentono fusi in un’unica entità. Come quando ci troviamo ad urlare a squarciagola le canzoni preferite durante un concerto con mille mila persone.
Questa condivisione emotiva rafforza il legame sociale e rende l’esperienza memorabile e significativa.
Ogni elemento del rituale è carico di simboli. La bandiera non è solo un pezzo di stoffa, ma rappresenta la nazione. Un monumento non è solo una scultura, ma incarna la memoria storica. I simboli sono essenziali perchè condensano significati complessi e valori astratti in oggetti e azioni che possiamo vedere e toccare.

Torniamo ora sulla piccola scala. Pensiamo ai quartieri. Pensiamo a un torneo di calcio tra rioni, a una corsa che attraversa tutte le vie del quartiere. Questi eventi, anche se non sono dei rituali nel senso più stretto, ne assumono diverse funzioni. Tornando ai micro-rituali prendiamo in considerazione i rituali dell’interazione di Goffman.
Secondo Goffman la vita sociale è permeata da una miriade di micro-rituali che compiamo senza esserne pienamente consapevoli.
Non hanno uno scopo pratico evidente, ma servono a mantenere l’ordine sociale.
A riguardo esiste un’opera di un’artista danese molto interessante e curiosa. Il fotografo Peter Funch ha visitato lo stesso punto di una delle principali strade di New York per diversi anni. Lì documentava i passanti, scoprendo diversi habituè.
Nell’arco di tempo dal 2007 al 2016, Peter ha quindi regolarmente preso parte al trambusto mattutino dell’area di Manhattan Midtown. Inizialmente il fotografo non aveva un vero e proprio scopo preciso, ma poco dopo ha iniziato a riconoscere alcuni volti tra la folla e ha quindi iniziato a fotografare gli stessi passanti. Giorno dopo giorno.
Denominata 42nd and Vanderbilt, dal nome della strada in cui si “appostava”, il suo lavoro è finito per essere una serie di ritratti.

Quello che è iniziato come un esercizio di individuazione di persone ricorrenti in una folla anonima, si è presto trasformato in una visione più complessa delle nostre abitudini e dei nostri rituali individuali. Vestiti, gesti e linguaggio del corpo ricorrono così frequentemente che alcune foto sembrano essere state scattate solo qualche momento di distanza l’una dall’altra. In realtà sono il risultato di un lavoro di settimane, mesi o anche anni.
La cosa particolare è che nonostante le persone siano state fotografate in minuziosi dettagli della loro quotidianità, sono allo stesso tempo completamente anonime. Per questo, nonostante le situazioni di tutti i giorni riportate possano essere familiari a molti, il framing fotografico genera un certo senso di distacco.
Questo perchè il lavoro di Peter Funch si inserisce in un contesto più ampio di pubblico e privato. Partendo dal pensiero di una società sempre più sotto controllo, il suo lavoro offre un commento sottile alla relazione in continuo cambiamento tra anonimato ed esposizione, pubblico e privato.
Peter parla dei suoi lavori come narrativi. Usa il termine romantico per descrivere gli eventi a cui assiste. La sua formazione parte nel 1999 studiando fotogiornalismo.

“Il giornalismo è cambiato molto negli ultimi vent’anni! Ci sono così tante forme di media, per non parlare l’aspetto finanziario di tutto ciò. Ci sono molto magazine, ma c’è anche un interessante nuovo modo di lavorare con lo storytelling, giornalismo e fotogiornalismo”.
Ma perchè parlare di nuovi media e fotogiornalismo in relazione ai rituali pubblici?
In realtà tra di loro esiste un rapporto molto stretto e complesso. I nuovi media, infatti, rappresentano un palcoscenico per i rituali. Non si limitano a raccontarli, ora li amplificano e qualche volta ne creano di nuovi. I social diventano quindi dei palcoscenici virtuali in cui i rituali pubblici vengono trasmessi in diretta, commentati in tempo reale e condivisi su scala globale. Chiunque abbia accesso a internet può parteciparvi, senza la necessità di essere presente fisicamente.
Il giornalismo e il fotogiornalismo da sempre svolgono un ruolo cruciale nella narrazione e nella documentazione dei rituali pubblici.
I giornalisti e i fotogiornalisti agiscono come interpreti culturali. Con gli articoli e le fotografie spiegano il significato di un rituale, il contesto in cui si inserisce e le sue implicazioni sociali. Un esempio è proprio il lavoro di Peter su quell’angolo preciso di New York.

In questo lavoro Peter diventa un romantico sognatore che torna sempre nello stesso punto cercando le stesse persone, ancora e ancora. L’idea arriva dal film “Smoke”, dove il protagonista scatta delle foto ogni giorno alla stessa ora. Anche qui ritorna il fascino del rituale, della ripetizione.
“Babel Tales” rappresenta un altro tentativo (ben riuscito) del fotografo di portare le relazioni umane in primo piano, sempre attraverso la narrazione di rituali e micro-rituali della vita urbana.
Si tratta di una serie fotografica realizzata sempre a New York. Il titolo, come si può immaginare, evoca l’immagine biblica della Torre di Babele e la confusione di lingue e culture che il fotografo applica al contesto della metropoli moderna.
Anche qui Peter si posiziona in un punto specifico della strada e scatta centinaia o migliaia di foto di passanti nell’arco di diverse settimane o mesi, sempre dalla stessa identica posizione. In seguito, seleziona con minuziosa attenzione i volti, le figure e i dettagli che mostrano un’azione o una caratteristica comune e li sovrappone in un’unica immagine composita. Ad esempio, può creare un’immagine in cui tutti i soggetti hanno un telefono all’orecchio, o in cui tutti sembrano guardare nella stessa direzione.

Quindi i micro-rituali vengono notati, fotografati e poi ricercati nelle diverse foto. Dimostrando così un comune denominatore in quelli che sono dei rituali potremmo dire quasi comuni. Il pezzo forte sta nel fatto che le immagini prese vengono da una metropoli gigantesca, dove il senso di alienazione è altissimo. Eppure Peter è in grado di creare un’immagine riprendendo 30 sconosciuti fare la stessa cosa nello stesso punto, ma in momenti diversi.
Questi due progetti, fatti allo stesso modo, illustrano due aspetti diversi della società. “Babel Tales” riguarda molto il momento collettivo, mentre l’altro si occupa del rituale individuale, della privacy in uno spazio pubblico.
E’ simpatico notare come, attraverso anche i micro-rituali, gli sconosciuti in una strada di una delle città più grandi del mondo riescono comunque ad avere qualcosa in comune. Un gesto, un modo di fare.
Ecco che qui ritorniamo al punto d’inizio: i micro-rituali, così come i rituali pubblici, ci accomunano come società. Anche quando siamo dei semplici sconosciuti in mezzo a una delle più grandi metropoli mondiali. Gli individui, pur non conoscendosi, seguono un copione non scritto per navigare lo spazio pubblico. Una “recita” della vita quotidiana, messa in atto attraverso nostri micro-rituali.